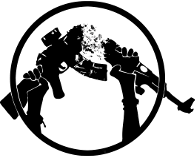Quando nel 2020, insieme alla pandemia, ha cominciato a dilagare il paradigma bellico per narrare l’impegno collettivo per salvare le vite, svolgendo una critica alla banalizzazione della realtà che questo comportava ed ai suoi rischi, scrivevo – tra le altre cose – che il continuo far ricorso al paradigma della guerra, allo sforzo bellico di chi è in “trincea” contro il virus, rimanda alla “ri/costruzione di un immaginario positivo della guerra come sforzo collettivo, come mobilitazione patriottica, come esaltazione della potenza militare”. In un Paese nel quale il pudore della guerra, insito nel “ripudio” costituzionale, faceva che sì che – fino a quel momento – veri interventi militari in giro per il pianeta fossero ossimoricamente definiti “missioni di pace”, la guerra – associata ossessivamente all’impegno di chi salva vite umane, invece di ucciderle – era tornata ad essere rivalutata come metafora di valore, anziché di disonore (queste riflessioni oggi si trovano in Disarmare il virus della violenza, 2021). Da lì ad un anno, questo paradigma avrebbe modellato la realtà, inverandosi nella nomina di un generale di corpo d’armata a Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, portando con sé notevoli implicazioni culturali e politiche nella ridefinizione dell’immaginario collettivo, che oggi si stanno manifestando in tutta la loro potenza di fuoco all’interno del passaggio repentino dalla “guerra” al virus al virus della guerra guerreggiata, in cui la “necessità” del coinvolgimento italiano – non in un processo di mediazione e interposizione tra le parti, ma attraverso l’invio di armi a sostegno di una parte (dopo un decennio di vendita all’altra, ndr) – è diffusa ossessivamente nella narrazione pubblica e confermata nelle scelte politiche. Eliminando qualunque possibilità di analisi più complessa dello schierarsi sull’attenti con l’elmetto in testa.
Il paradigma della logica binaria
Definisce il problema, con la consueta lucidità, anche la politologa Nadia Urbinati nell’editoriale sul quotidiano Domani del 5 marzo del 2022, mettendo a fuoco la logica binaria nella quale siamo fortemente indotti, strutturalmente insita nel paradigma bellico. “Il paradigma della logica binaria ammette una sola direzione di marcia” – scrive Urbinati – “E come ogni approccio monotematico tende ad estremizzare. Crea un ambiente retorico che non lascia (non deve lasciare) spazio al dubbio; che non favorisce un’analisi degli eventi, ma solo reazioni emotive a quegli eventi che trangugiamo come fossero vino buono; che scoraggia la formazione di opinioni interlocutorie e capaci di presentarsi per quel che sono, ovvero punti di vista aperti alla contestazione e alla revisione. Le opinioni che sono confezionate dal rullo compressore del paradigma binario si impongono a noi come fatti granitici e oggettivi – impermeabili al giudizio critico. In questo clima si promuove non la conoscenza degli eventi ma una religiosa adesione. Non si facilita la simpatetica disposizione verso le sofferenze umane, ma si alimenta l’emozione unidirezionale pro/contro, come se fossimo tutti noi sul campo di battaglia”
Il martellamento sull’unica risposta possibile
E’ montata, infatti, con incredibile velocità sui mezzi d’informazione del nostro paese e nelle scelte politiche – quasi unanimi – il martellamento sul dovere di partecipazione attiva alla guerra, attraverso l’invio di armi all’Ucraina (dopo averne venduto per almeno un decennio anche alla Russia, in violazione della legge 185/90 oltre che della Costituzione) come unica risposta possibile, con il corollario dell’esplicita accusa di “filoputinismo” a chi provi ad esercitare minimamente il pensiero critico contro questa nuova banalizzazione della ragione, con una virulenza inimmaginabile solo qualche anno fa, prima della dilagante retorica bellica degli ultimi due anni che ha colonizzato l’immaginario. “Oggi”, osserva il collettivo Wu Ming, “in molte dichiarazioni, in molti titoli di giornale, basterebbe rimpiazzare «Putin» con «il Covid» per vedere che tra le due retoriche belliche c’è piena continuità”. Anche le importanti manifestazioni spontanee per la pace e per la solidarietà con il popolo ucraino sono state “interpretate” non solo in Italia ma da tutti i governi europei, e dai rispettivi parlamenti (quasi senza eccezione) – come in una perfetta distopia orwelliana: “guerra è pace”- come un mandato per indossare mimetica ed elmetto ed entrare di fatto in guerra, aggiungendo ad un incendio altro materiale imfiammabile. Parimenti, come sempre succede in questi casi, l’informazione si è trasformata in propaganda bellica, alimentando un clima di odio anche nei confronti della cultura russa tout court – dal quale è stato incredibilmente travolto perfino Dostoevskij, non al bar ma in una prestigiosa istituzione universitaria – e di accusa di fraternizzazione con il nemico per chi dissente da queste scelte e prova ad articolare un ragionamento un po’ meno banale e più aderente al mandato costituzionale.
Svelare la banalità del male della guerra
Si tratta della violenza culturale che dispiega tutto il suo potenziale di supporto e legittimazione della guerra e delle armi come unica strategia possibile di fronte ad una aggressione militare, senza averne mai costruito alternative possibili e credibili, proposte per tempo dai movimenti per il disarmo e la nonviolenza: è l’uomo col martello che vede tutto il mondo come un chiodo e agisce ottusamente di conseguenza. Allora, contemporaneamente all’impegno prioritario per il cessate il fuoco in Ucraina e alla solidarietà con le vittime, è necessario impegnarsi anche per arginare il bombardamento bellico delle nostre menti e svelare la banalità del male della guerra, attraverso un rinnovato impegno culturale ed educativo volto a disarmare il pensiero, che rimetta al centro dell’attenzione e del discorso pubblico sia importanti consapevolezze oggi colpevolmente rimosse sia la decostruzione delle fallacie di una ragione che, indossando l’elmetto, rinuncia all’esercizio critico. Come abbiamo scritto più volte, ormai solo l’educazione ci può salvare (vedi anche Disarmare il virus della violenza).
Recuperare la coscienza del pericolo
Il primo recupero da fare è quello della coscienza del pericolo del vivere immersi all’interno di una nuova, impetuosa, corsa globale agli armamenti che in vent’anni – ossia dall’invasione dell’Afghanistan nel 2001, a cura di USA ed alleati, conclusasi solo lo scorso agosto – ha raddoppiato la spesa militare globale degli stati (e i relativi profitti dell’industria bellica internazionale, ndr) e oggi – senza soluzione di continuità e senza alcuna valutazione o autocritica sul disastro realizzato in quel martoriato paese – sta accelerando ancora di più la crescita con il pretesto della crisi ucraina, identificando nel “pericolo russo” il nuovo nemico pubblico numero uno contro cui armarsi sempre di più. Reciprocamente, ovviamente. Complementare a questa c’è l’altra, più radicale, rimozione da recuperare alla coscienza, quella del pericolo nucleare: c’è un arsenale nucleare di circa quattordicimila testate di ultimissima generazione puntato contro le teste di tutti che, ancorché illegale dopo il Trattato ONU di proibizione delle armi nucleari (ma non sottoscritto proprio dai possessori di queste armi, compreso il nostro paese facendone così un potenzile target), anziché lo smantellamento, ne vede oggi di nuovo la minaccia di uso e di mutua distruzione assicurata. Bisogna ritrovare, dunque, “il coraggio di avere paura” come ribadiva il filosofo Günther Anders, per esempio, nelle Tesi sull’età atomica nel denunciare il nuovo status di precarietà dell’umanità dopo Hiroshima – “quelli-che-esistono-ancora” – e come ci ricorda, inascoltato, il Bollettino degli scienziati atomici con le lancette dell’Orologio dell’Apocalisse fissato consecutivamente da tre anni a soli 100 secondi dalla mezzanotte nucleare.
Fare ecologia della mente
Rimesso al centro della nostra attenzione consapevole questo scenario del quale è ineludibile tenere conto, pena trascinare tutti in una immane tragedia per l’umanità intera, ci sono da decostruire alcune fallacie, errori di valutazione, che tutte le narrazioni belliche portano sempre con sé, alle quali bisogna porre grande attenzione, esserne avvertiti – fare ecologia della mente – per consentire la visione più ampia e prospettica possibile della realtà, a supporto della capacità di svolgere esercizio di pensiero critico, non militarizzato, alla ricerca si soluzioni non catastrofiche al conflitto in corso ed a tutti gli altri. Ecco, di seguito, le principali questioni di cui tenere conto, cercando di evitare gli errori nei quali hanno spesso indotto e possono ancora indurre.
1. La verità è la prima vittima di ogni guerra
La verità è la prima vittima di ogni guerra: per convincere le rispettive opinioni pubbliche della necessità della guerra, per averne il consenso nelle gravi decisioni politiche che questo comporta, sia che si tratti di parteciparvi direttamente con l’invio di militari che indirettamente con l’invio di armi, si tende ad allineare l’informazione nell’amplificazione delle proprie ragioni e nel depotenziamento di quelle degli avversari. E’ un dato universale, non una prerogativa delle sole dittature o autocrazie come quella putiniana: è un caso paradigmatico di studio – oltre che una tragedia per il popolo irakeno – il modo in cui l’invasione dell’Iraq da parte degli USA e dei suoi alleati democratici, compreso il nostro paese, fu preparata tra il 2002 e il 2003 attraverso la costruzione e l’esibizione di “prove” totalmente nventate di armi di distruzioni di massa di cui il regime di Saddam Hussein sarebbe stato in possesso. “Notizie” false, ma avallate e rilanciate in modalità martellante da tutte le principali testate giornalistiche internazionali. Solo ad occupazione militare fatta, con il suo portato di centinaia di migliaia di vittime e di genesi e sviluppo del terrorismo fondamentalista, fu ammesso il deliberato inganno da parte del segretario di stato USA Colin Powell e dell’allora presidente britannico Tony Blair, al fine di convincere l’opinione pubblica occidentale, ampiamente contraria a questa nuova guerra della sua “necessità”.
2. Gli uomini e il fuoco
In molti casi la deformazione della verità si spinge fino alla deumanizzazione dell’avversario: è un fenomeno ampiamente studiato (vedi per esempio Chiara Volpato, Deumanizzazione. Come si legittima la violenza, 2011) che consiste nella mostrificazione del nemico di turno, fino alla sua ricorrente reductio ad Hitler, ossia al male assoluto, tale da giustificare qualunque azione armata contro di lui e, ovviamente, il suo popolo. Questo meccanismo è raccontato, per esempio, in maniera efficace attraverso la fiction in un episodio della serie tv Black Mirror, Gli uomini e il fuoco, dove si racconta di un esercito ai cui militari viene impiantato nel cervello un dispositivo elettronico che trasforma in mostri, nella loro percezione, coloro che vengono indicati dai comandanti come i nemici: i soldati non ricordano nulla della vita precedente e danno la caccia spietata a questi esseri, chiamate “parassiti”, che a loro appaiono effettivamente mostri sia nelle fattezze fisiche quanto nei suoni che emettono. Finché il dispositivo mentale di un soldato si inceppa e il militare – riconoscendo nelle vittime gli esseri umani e comprendendone la lingua – si rende conto di ciò che sta facendo e si rifiuta di proseguire. Una volta arrestato e isolato dagli altri, lo psicologo dell’esercito gli spiega che durante la prima guerra mondiale solo il 15% dei soldati sparava davvero ai nemici perché inibito dalle caratteristiche umane dell’avversario e su questo “difetto di umanità” l’esercito ha lavorato per disinibire la capacità di fare violenza: con le normali tecniche di addestramento si era riusciti ad arrivare al 75% (per esempio in Vietnam), ma adesso il dispositivo che de-umanizza e mostrifica l’altro, garantisce il 100% del risultato. Ossia la disponibilità totale ad uccidere, senza se e senza ma. Fuori dalla fiction il processo di deumanizzazione culturale e informativo, in azione in questa e in tutte le guerre, è funzionale allo stesso scopo (vedi anche qui). Bisogna riconoscerlo per starci alla larga.
3. Occhio non vede cuore non duole
Tutte le informazioni che a noi arrivano dalle guerre, provengono da un unico punto di vista, quello della parte nella quale siamo collocati. E non sempre è il punto di vista delle vittime. Nella guerra in Ucraina, i media internazionali sono ampiamente presenti sul terreno e raccontano, momento per momento, la sofferenza del popolo ucraino, sotto l’aggressione russa, la sua resistenza e il drammatico esodo dei profughi coinvolgendoci emotivamente nell’empatizzare naturalmente con le vittime. In altri casi non è andata così, ma ha prevalso il vecchio adagio “occhio non vede, cuore non duole”: alcune guerre non le abbiamo affatto viste, perché nessuno ce le ha raccontate (per esempio la stessa guerra nella regione ucraina del Donbass che andava avanti fin dal 2014) e non le vediamo perché nessuno ce le racconta, come le molte altre guerre in corso in questo momento (dal Congo, alla Siria, allo Yemen, combattute anche con armi occidentali) ed occupazioni militari (per esempio nei territori palestinesi da parte di Israele); altre guerre le abbiamo viste poco e solo dalla parte degli aggressori, per esempio le già citate occupazioni militari in Afghanistan ed Iraq. In questo caso non vediamo la sofferenza delle popolazioni e, dunque, non empatizziamo con loro. Chi ha provato a raccontarle, per esempio Julian Assange attraverso Wikileaks, mostrando per esempio come i droni armati USA, anziché colpire obiettivi militari, colpivano (fino ai giorni della fuga precipitosa dall’aeroporto di Kabul dello scorso agosto) famiglie di civili, marcisce in una prigione inglese in attesa di essere estradato in una statunitense, esattamente per aver dis/velato la verità di quelle guerre, dalla parte delle vittime, come oggi fanno, giustamente, i media occidentali in Ucraina. E come non hanno fatto invece, colpevolmente, con i profughi delle altre guerre – respinti violentemente nel gelo dell’inverno in quegli stessi confini della Polonia che oggi accoglie i profughi ucraini – dei quali non conosciamo la sorte.
4. Prendere prospettiva per comprendere i conflitti
Con questo stato dell’informazione di guerra che, come abbiamo visto, sconfina spesso nella propaganda bellica, a volte, nella menzogna ed è fortemente condizionato dal punto di vista unidirezionato, per comprendere le ragioni per le quali ad un certo punto un conflitto deflagra in guerra aperta e viene portato in primo piano all’attenzione dell’opinione pubblica – e poterne comprenderne portata e, quindi, possibili soluzioni – non sono sufficienti le istantanee, ossia la cronaca di ciò che avviene in questo momento, ma è necessario fare tre operazioni: andare in profondità, allargare lo sguardo nel tempo, aprire la cartina geografica nello spazio. Come insegnano i teorici internazionali dei conflitti, da Johan Galtung (vedi Pace con mezzi pacifici, 2000) a Pat Patfort (vedi Difendersi senza aggredire, 2006) non si può comprendere nessun conflitto – e di conseguenza contribuire a risolverlo – se non se ne conosce la storia ed i meccanismi di escalation, al di sotto della soglia di visibilità, che lo hanno portato fino alla deflagrazione attuale che – solo ora – tutti guardiamo (anche se solo dal nostro punto di vista). Questo è vero in tutte le dimensione dei conflitti, da quelli interpersonali a quelli internazionali, ma è particolarmente vero per i conflitti tra stati, dove in un sistema di relazioni complesse e interconnesse (dove il battito d’ali di una farfalla in una parte del mondo può generare un uragano da un’altra parte, come sanno i meteorologi), bisogna riconoscere e comprendere – contemporaneamente – quanto accaduto nelle dinamiche tra Russia e Ucraina, fino ad oggi, andando appunto in profondità, come ho provato a fare qui, ma anche quanto accaduto nelle politiche di potenza tra stati egemoni nell’ultimo trentennio, allargando lo sguardo nel tempo e nello spazio, come ho provato a fare qui.
Dunque, quali sono le alternative?
Arrivati a questo punto, con la consapevolezza dei pericoli globali e sgombrato il campo dalle fallacie cognitive, affido la risposta alla fondamentale domanda su quali possono essere le alternative all’invio di armi nel contesto di guerra in Ucraina (oltre che alla rilettura degli articoli ai link precedenti) a questa ampia video-intervista.